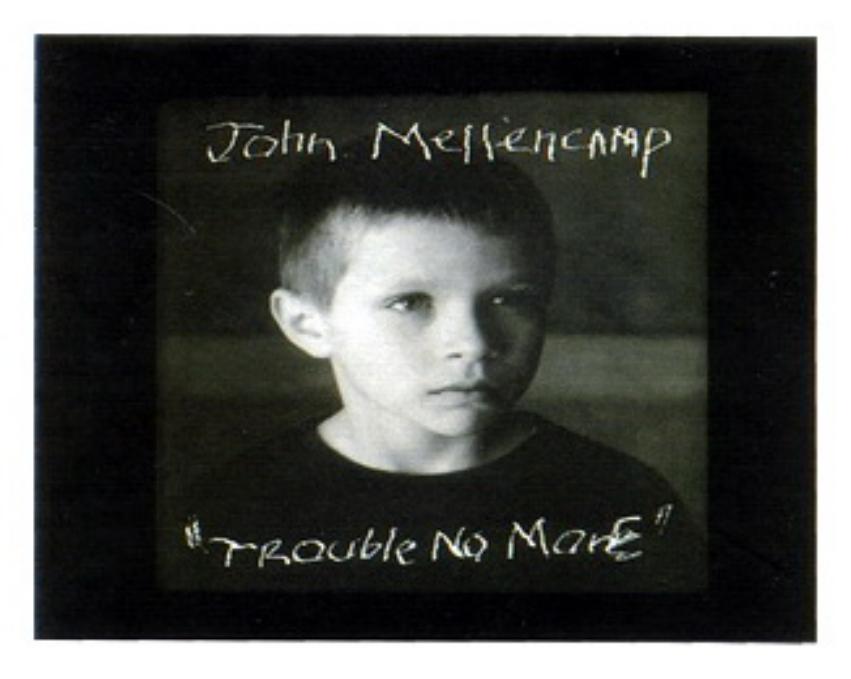
Penso sia dal tempo di
Human Wheels, 1993, che John Mellencamp, non fa un disco come si deve.
Cuttin' Heads, il suo ultimo lavoro (2001), aveva parecchie frecce al suo arco ma finiva con il convincere solo parzialmente.
Trouble No More invece convince sin dal primo ascolto. Si tratta di un disco di covers, di brani presi dalla tradizione, da quel grande bacino che è la musica americana. Già per come è costruito il disco risulta meritevole: suoni secchi, asciutti, strumentazione all'osso, blues, folk e musica delle radici interpretata con voglia e grande vitalità.
John non ha mai lasciato nulla al caso, quando ha sbagliato lo ha fatto in modo grossolano, quando ha fatto le cose giuste ha sempre pubblicato grandi dischi. Ed anche in questo caso il rocker dell'Indiana riesce a cavare dal suo cilindro un disco coi fiocchi.
Trouble No More è stato preceduto dal clamore suscitato da
To Washington, una canzone originale di Mellencamp che si ispira a Woody Guthrie, che il nostro ha fatto diventare una violenta invettiva nei confronti di Bush e del sistema guerrafondaio americano. Ognuno è libero di pensarla alla sua maniera e Mellencamp ha gridato ai quattro venti la sua voglia di giustizia e libertà e questo fatto, specie in Usa, non gli ha portato certamente dei vantaggi, viste le reazioni di parte del pubblico, alcune molto violente, nei suoi confronti.
La canzone è una splendida ballata acustica che John ha rimesso in pista alla sua maniera: ha mantenuto la melodia e con la voce roca ha acuito la drammaticità del testo e, accompagnato da una chitarra, un violino e poco altro, ha lanciato nell'etere una canzone esplosiva in cui arte e mestiere vanno a braccetto, con il risultato di dare una scossa violenta all'establishment facendo però grande musica. Questo è un po' il motivo conduttore del disco. Un disco fuori da ogni schema che non avrà l'appoggio delle radio ma che riporterà dalla sua parte una bella fetta di pubblico. Se lo merita. L'album si apre con il blues secco e ritmato di
Stones in My Passway una canzone che arriva dal repertorio di
Robert Johnson. John mantiene il ritmo, la strumenta leggermente (batteria acuminata e slide guitar), e riesce a catturare l'anima della musica di Johnson.
Ancora blues con
Death Letter, composta da un altro monumento,
Son House. La chiave di lettura è simile, la musica è rozza, sporca, la voce tesa come una lama. Un blues disperato, spoglio e vibrante. Un inizio folgorante, in completata antitesi con quello che il mercato richiede oggi. La musica che John propone non è accondiscendente, non si piega ai voleri delle classifiche. Appartiene al filone
Love it or Leave it. Prendere o lasciare.
Johnny Hart è una toccante ballad di
Woody Guthrie, il folk hero per antonomasia. Mellencamp non cambia molto l'assunto: tempo veloce, chitarra dietro alla voce, drumming sgangherato, un violino sul fondo. Il tutto al servizio della voce che riprende una melodia senza tempo, la fa sua, ci mette il cuore ed il cervello e ci fa tornare indietro di cinquanta anni e più, quando un tizio con una chitarra combatteva una battaglia impari.
I tempi sono cambiati ma certe cose esistono ancora ed il piccolo rocker dell'Indiana si erge a baluardo nei confronti di una società schiacciasassi, portando la musica a combattere i colossi, le corporation.
Baltimore Oriole arriva dal repertorio di
Hoagy Carmichael (colui che scrisse
Stardust e molti altri standard) ed è una rilettura rigorosa in chiave molto old fashioned. Anche qui pochi strumenti, una melodia triste, una fisarmonica che la sfiora. L'intro di
Teardrop Will Fall ricorda un periodo felice della vita di John, quando era in cima al mondo e pubblicava dischi come
Scarecrow, Lonesome Jubilee e Big Daddy, ed aveva in parte precorso l'avvento dell'alternative country inventandosi un suono. La canzone è un vera sorpresa ed arriva dal repertorio, a noi decisamente sconosciuto, di un gruppo satellite,
Dickie Do and the Don'ts.
Una band esistita tra la fine dei cinquanta ed i primi sessanta, creata da Gerry Graham come aiter ego per registrate le sue canzoni. Il geniale Graham (non c'è nulla di lui in CD) ha avuto alcuni successi tra cui Teardrops Will Fall, che John riprende con un suono corale e la band al completo. E regala una canzone vera, una ballata degna delle sue cose migliori, cantata con l'anima e suonata in modo corale. Una bella riscoperta, John.
Diamond Joe è invece un classico della musica tradizionale americana, l'abbiamo conosciuta attraverso le registrazioni di
Ramblin' Jack Elliott e
Tom Rush, ma l'hanno interpretata in parecchi (Harry Belafonte, Don Edwards, Joe Val, Jerry Garcia, Cisco Houston).
Anche in questo caso John usa un arrangiamento corale, con la band, con le voci femminili che fanno da contrappunto alla sua e trasforma la folk song in un ballata epica, regalandole un substrato melodico notevole. Una rilettura piena di inventiva.
The End of the World la ricordano quelli della mia età. Era una slow country ballaci, una heartbreak song, resa celebre all'inizio dei sessanta da
Skeeter Davis (numero due nelle classifiche Usa nel 1963). John la suona in modo più rock, lascia il violino ma le toglie la patina country, mantenendo però la melodia suggestiva e coinvolgente. Un love song come oggi non se ne scrivono più.
Down in the Bottom appartiene al repertorio di quel grande bluesman che è stato
Willie Dixon.
Mellencamp torna alla formula dei primi due brani e, un po' come ha fatto David Johansen, rilegge il blues in modo secco, scarnificato, ma con meno eleganza e più rudezza. Un'altra sorpresa è la struggente cover di
Lafayette, splendida canzone della nostra beniamina
Lucinda Williams, che il rocker dell'Indiana interpreta da par suo. Base acustica, un gruppo di voci che cantano all'unisono e la melodia malinconica, struggente e densa di rimpianto, viene a galla in modo inequivocabile, grazie anche all'uso insistito di una fisarmonica.
Altro brano storico è
Joliet Bound, che arriva dal repertorio di Joe Me Coy, conosciuto meglio come
Kansas Joe, attivo negli venti e trenta e marito della grande Memphis Minnie. Un altro blues potente, introdotto da una chitarra acustica, ma reso in modo diverso dai precedenti. Qui John mischia folk e blues, tiene in campo il mandolino, mentre articola molto le percussioni, ed usa la voce quasi in secondo piano rispetto alla musica. Siamo quasi alla fine. Ma ci sono ancora due brani di valore. Il blues tradizionale
John the Revelator, reso celebre da
Son House, eseguito con le sole voci, John e due voci femminili, a cui fa da contrasto una chitarra dura. Una versione densa e scura, che si tinge quasi di gospel e ha il sapore di certi canti del Sud, dove le voci giocano sempre un ruolo fondamentale. La già citata
To Washington chiude l'album. 46 minuti di vera musica che ci riportano uno che pensavamo di avere parzialmente perso per strada.
Ma quanto a carattere e coraggio John non è secondo a nessuno, come conferma
Trouble No More.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE