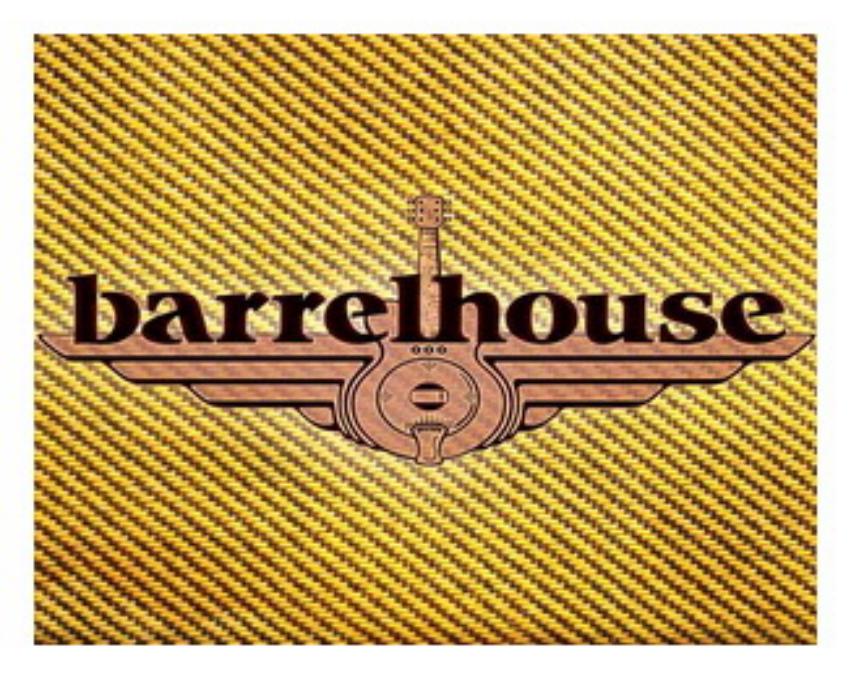 Barrelhouse
Barrelhouse, letteralmente, era un saloon dove il menù offriva solitamente alcohol, donne di facili costumi e gioco d’azzardo (quello che poi si è evoluto negli Honky-tonk music bar del centro-sud Americano), da lì è partito il sestetto della Virginia. Anno 2006, tante le influenze nel sound, base a Chicago, strada aperta per il Texas Blues e fermata obbligatoria sulle sponde del Delta Mississippi, una miscela che sfocia in un esordio grintoso, fatto di blues, chitarre e rock ‘n’ roll da saggiare tutto d’un fiato sin dall’accoppiata iniziale di
Won't Be Long e
Cold Woman.
Barrelhouse è brusco ma si interrompe spesso, l’ascoltatore è convocato in quelle fessure spazio-temporali innescate dalle interruzioni dell’armonica di Tom Mayer e dalla chitarra di Brandon Martin, echi sonori anni ‘60 e ‘70 terribilmente geometrici nell’itinerario di
Shot of Blues e la deliziosa
Iced Tea, un percorso circolare battuto anche nelle spumeggianti
Don't Be Surprised e
Must Have Been the Shine.
L’aria che tira in
Barrelhouse è quella di chi non conosce ragioni e va avanti per la propria strada con maniacale stravaganza, nelle tradizioni del blues e del rock lasciando le atrocità e le banalità della vita suburbana confinate nelle zone d’ombra, alla luce del sole brillano solo l’armonica, vitale in
Have You Got Love, e le chitarre in
Easy Come, Easy Go.
Scorrono via come un fiume, senza intorcicarsi sulle stesse melodie ma alimentandosi, fino alla fine, al fuoco della passione del rock/blues, tra
Young Man e
Blue Eyes.
Barrelhouse è da ascoltare ad alto volume, soprattutto in quelle stanze polverose dove regna l’arteriosclerosi e in quei salotti percorsi da una estenuata malinconia senza rimedio.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE