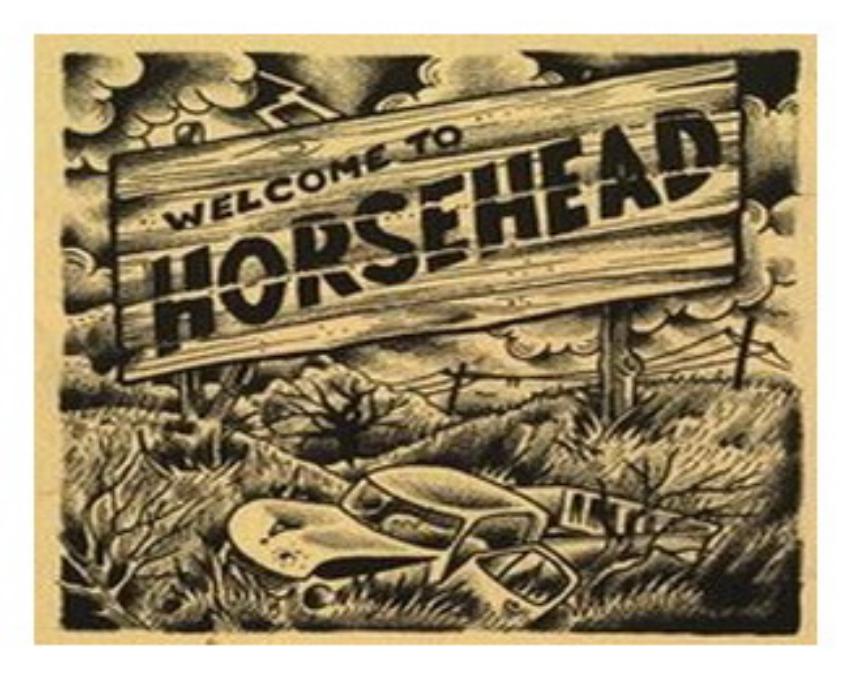
Secondo album per gli
Horsehead che avevano lasciato tracce del loro cammino con il precedente Record of the Year, e senza abbandonare le armonie alla Petty, le chitarre e i refrain di qualche passato decennio riescono ad infarcire il loro songwriting e la loro musica con intense e piacevoli armonie, che sebbene sguazzino nel sottobosco della malinconia, spiccano un balzo pieno nella speranza grazie all’aria frizzante che si sprigiona dalle loro chitarre.
Welcome to Horsehead non poteva che iniziare con storie di incontri e di avvenimenti tristi e felici allo stesso tempo, una
Heartbreaking Song che sottovoce spazia nel roots e nessuna avvisaglia appare all’orizzonte mentre i riff energici di
Jimmy’s Song iniziano a prendere consistenza e ci calano di colpo nel fervore degli anni ’70, piano piano ma la delizia della coda chitarristica finale è un gran bel biglietto da visita, la strada è lanciata, il piano aggiunge spessore in
Walk Off e la magia continua, deliziosa, coinvolgente con un’armonica fiera a suggellarne la qualità.
Si corre in scioltezza e al giro di boa assestano un paio di scossoni, dalla splendida
Don’t Call Me che testimonia la qualità degli Horsehead, uno slow-rock intenso ad una ballata roots incantevole come
Hogtown che gioca su una strumentazione elettro-acustica e sulla coralità del refrain. Ma non ci si siede nemmeno per un istante, quindi ecco la nervosa
Lost Love Line altro rock limpido come anche
Too Late to Run, le tonalità rootsy della guizzante
Bottom of a Glass, al rockaccio da bar-room di
Always Break Even per chiudere alla grande con il delizioso messaggio di una lodevole schitarrata in
I Need a Good Day, con un refrain che non si può non cantare a squarciagola mentre i riff alzano il ritmo, per chiudere con i quadretti rootsy da un matrimonio, dove la malinconia di un pianoforte abbraccia i ricordi e
Welcome to Horsead afferma la sua bellezza cristallina.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE