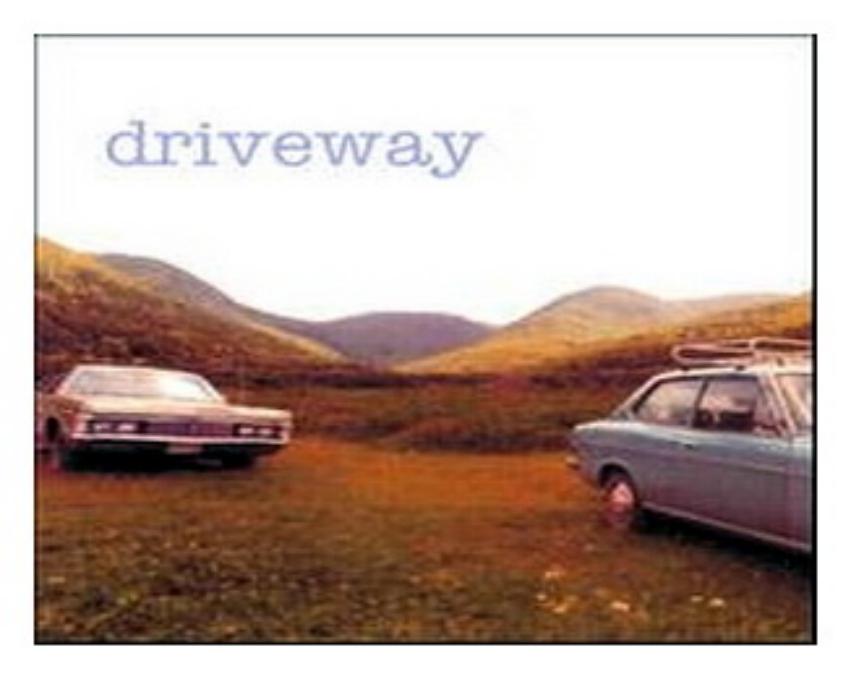
A confermare, una volta ancora, che delle apparenze bisogna fidarsi il giusto, ecco arrivare da una benemerita etichetta tedesca l'esordio degli americanissimi
Driveway. La spettrale immagine - una highway seppiata e un'automobile che corre nella notte - della copertina, le foto dei membri della band (intenti a sorseggiare una birra dal bancone di un bar), e una ragione sociale che da sola evoca movimento, fughe verso il nulla e solitudine, farebbero supporre di trovarsi di fronte all'ennesima propaggine dell'alt.country maggiormente devoto ai clichés del genere… e invece no. Innanzitutto, i Driveways non sono di primo pelo, poiché il frontman e chitarrista Jason Taylor si trova alle spalle l'esperienza major dei MAdE (un album all'attivo per la Mca, Television Heart); dal medesimo gruppo proviene il bassista Chris Sytnyk, mentre il banjo di Corey Matheson e il drumming di Robin Mason appaiono relativamente vergini - dal punto di vista discografico, s'intende.
Il loro sound, poi, seppur indubbiamente legato ai temi e alle suggestioni del migliore rock a stelle e strisce degli ultimi anni, è senz'altro più originale, denso e articolato rispetto alla media delle formazioni di aria "insurgent": sarà la produzione accorta di Keith Cleversley (Flamin Lips, Spiritualized, Urge Overkill), sarà l'ampio raggio d'influenze - una striscia che parte da Jayhawks e Whiskeytown e transita per i languori brit di Coldplay o Travis per approdare alle dissonanze dei Sonic Youth - dichiarato a parole, nonché proficuamente espresso attraverso le canzoni, ma è certo che in diversi momenti di questo omonimo debutto -
Butterfly, Suffering, Tomorrow - si respira un felice venticello wave cui è difficile resistere.
Tuttavia, il baricentro del disco è piantato su di un rock'n'roll tanto esemplare quanto efficace, su di una sezione ritmica di innegabile ascendenza stonesiana sulla quale si innesta un vero e proprio wall of sound chitarristico. Cosa sono, infatti, le varie
Angels, Loneliness, Always o
Kiss, se non una coinvolgente variazione sul tema del mid-tempo alla Stones, magari arricchite da un azzeccato tappeto d'organo, fascinosi dettagli roots, il controcanto di Stella Panacci (tanto per tributare omaggio pure a Lucinda Williams) e uno spleen disilluso che aveva trovato massima espressione di sé nel Ryan Adams di Strangers Almanac? Ed è ancora a Ryan Adams, stavolta quello massimalista e sfacciatamente classico di Gold, che corre il pensiero durante l'ascolto del capolavoro del disco, cioè a dirsi la devastante
Revolving: drive mordace da bar-boogie band perennemente su di giri, voce distaccata alla Lou Reed, pioggia di watt e chitarre nel gran finale.
Just a story from America? Decisamente qualcosa in più.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE