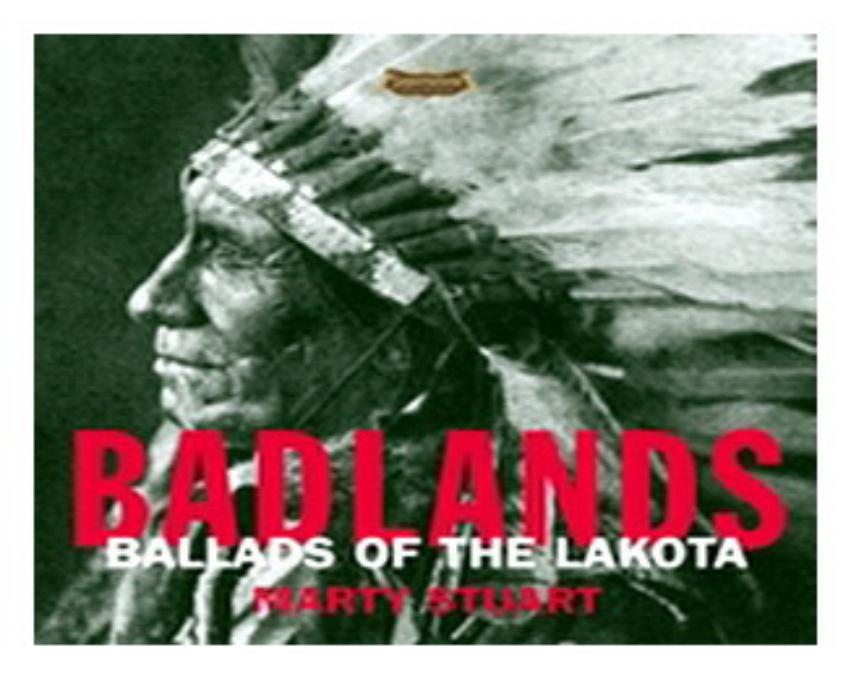
Un particolare che si tralascia spesso, parlando di
Marty Stuart, è quello della sua certo non eccessiva prolificità di scrittura: sin dall'esordio di Marty,
With A Little Help, From My Friends, negli anni 70, il nostro si è sovente appoggiato a brani altrui o a svariati collaboratori coi quali condividere i crediti del songwriting. Perciò mi sembra importante specificare che
Badlands - Ballads Of The Lakota è il primo album (quasi) interamente scritto da Marty dai tempi di
The Pilgrim (1999). L'eccezione c'è, ovviamente, e s'intitola
Big Foot, un brano poco conosciuto di
Johnny Cash che Marty interpreta con devozione e carattere.
In effetti, se bisogna trovare un nume tutelare all'intera operazione, questi sembra non poter essere che Cash: non solo perché Marty aveva fatto parte della sua band (dopo essere stato al servizio di Lester Flatt) all'incirca vent'anni fa, ma anche perché l'intero
Badlands è stato prodotto sotto l'egida di
John Carter Cash (figlio di Johnny e June) e la peculiare cifra stilistica del man in black serpeggia un po' in tutto l'album. Ci si potrebbe chiedere perché pubblicare un disco nuovo a cosi breve distanza dal country-gospel del recente
Souls' Chapel, ma il motivo è piuttosto chiaro e lo spiega lo stesso Marty Stuart: "
Credo che le Badlands (il territorio dei Sioux Lakota, 244.000 acri di terra nella parte ovest del South Dakota) e quelle del delta del Mississippi siano le regioni più povere d'America. Ma la dignità e il cuore delle persone sono ancora vivi nonostante un secolo di ingiustizie e difficoltà."
Impossibile, quindi, non leggere in questi due album una critica nemmeno troppo velata alla spaventosa dissoluzione del concetto di welfare state portata alle estreme conseguenze dall'attuale amministrazione statunitense, così com'è impossibile non leggere, tra le note di
Badlands, un commosso omaggio a
Bitter Tears -Ballads Of The American Indian, il disco (tanto breve quanto folgorante) col quale, nel 1964, Johnny Cash s'imbarcò in uno storico viaggio attraverso le sofferenze, i personaggi e le leggende della popolazione nativa. Accompagnato dai fidati Fabulous Superlatives, cioè
Harry Stinson (batteria),
Brian Glenn (basso) e
Kenny Vaughan (eccezionale chitarra),
Marty Stuart torna oggi a ripercorrere quegli stessi sentieri, nel tentativo di dare voce e visibilità a chi ha subito più di un tentativo di cancellazione da parte della partigianeria di certa storiografia "ufficiale": ne è fuoriuscito un album di grande spessore, cui nuoce soltanto, se proprio si vuole spaccare il capello in quattro, un atteggiamento eccessivamente "didattico" e trattenuto, quasi didascalico, nei confronti della materia in esame (ma è un piccolo problema che Marty ha sempre avuto).
Al di là degli intermezzi strumentali à la Robbie Robertson (quello di
Music For The Native Americans e
Contact, From The Underworld Of Redboy, naturalmente), cui è dimandato il compito di offrire una cornice ambientale alle tematiche dell'opera, rincalzante titletrack, il graffio bluesy di
Trip To Little Big Horn e la malinconia roots di
Wounded Knee certificano ancora una volta l'abilità di Marty nel maneggiare il country-rock. Ancora meglio sono il rock'n'roll incalzante e polemico di
Broken Promised Land, poi doppiata in carica epica dalla maestosa
Walking Through The Prayers, e la maturità tradizionalista di
So You Want To Be An Indian, quest'ultima la migliore delle epigrafi per un progetto rischioso, importante e riuscito.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE