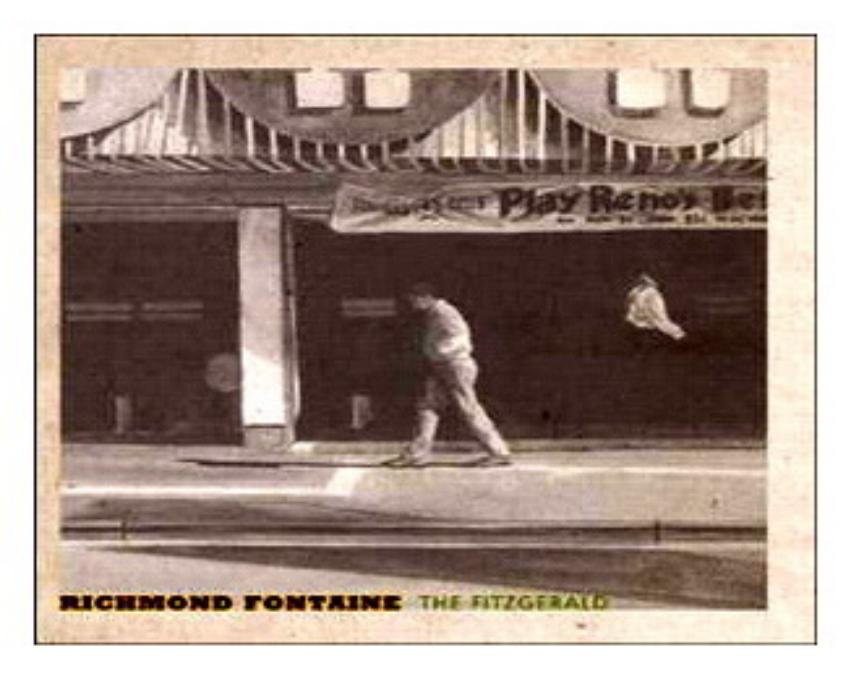
Voce spezzata, ballate folk notturne e affilate come una lama dove i silenzi hanno un ruolo determinante quanto la musica: dopo la messe di applausi ricevuta dalla critica specializzata grazie al loro
Post to Wire i
Richmond Fontaine, descritti come ultimi e più credibili paladini della lunga tradizione partita con gli Uncle Tupelo, passano ad una visione ancora più angosciante e pessimista dell'America di provincia. Se già il precedente lavoro metteva in risalto la malinconia di fondo del loro country rock polveroso e di frontiera, adagiato però su sonorità nervose ed elettriche,
The Fitzgerald spiazzerà anche i più affezionati sostenitori con una visione scarna, quasi si trattasse del Nebraska dell'alternative country.
Lasciando da parte difficili accostamenti, il richiamo all'opera di Springsteen serve a mettere in luce le storie di perdenti e le sconfitte inesorabili raccontate in questo disco da
Willy Vlautin, da sempre voce e anima dei
Richmond Fontaine. Chiuso per due settimane in un hotel casinò di Reno, Nevada, Vlautin ha registrato la variegata umanità di passaggio, imprimendola nei solchi di
The Fitzgerald. Nuovamente prodotto da
JD Foster negli studi casalinghi di Portland, il lavoro non lascia spazio alla speranza, costruendo un suono spartano che ricorda il deserto di Howe Gelb e dei Giant Sand. Il ruolo principale spetta alla voce e alla chitarra acustica di Vlautin, accompagnato dal fido Paul Brainard, il quale, abbandonata l'inseparabile pedal steel, si è dedicato questa volta al piano.
La sezione ritmica si affaccia di rado, lasciando campo aperto alla desolazione di
The Warehouse Life e
Welhorn Yards, brani che sembrano percorsi da polvere e sibili in sottofondo. Disco ostico, concettualmente molto affascinante, ma forse un po' azzardato per chi non possiede una statura artistica fuori del comune: Vlautin non è Johnny Cash e tanto meno Bruce Springsteen, i suoi diavoli e la sua polvere incontrano più difficoltà ad emergere.
In
Black Road affiora una tensione dettata dagli stridori elettrici in lontananza, la malinconia assale
The Incident At Conklin Creek, un groppo alla gola arriva con
Disappeared, dove sbuca una batteria appena accennata, mentre piano e violino riempiono i vuoti in lontananza. Non si discutono le motivazioni dell'intera operazione, ma i
Richmond Fontaine sembrano credere troppo nella forza della narrazione e a volte trascurano la cura dei dettagli. È probabilmente un attegiamento voluto, che raccoglie consensi in
Casino Lights, inquieta ballata da confine condotta da violino e chitarra, nella più vivace
Don't Look And It Won't Hurt, che ricorda alcune cose di Jay Farrar, oppure in
Exit 194b, un country sbilenco e arido come il deserto, dall'andatura più corale. Sono sprazzi, bruscamente interrotti dalla solitudine di
Laramie, Wyoming, The Janitor e
Making It Back. Questa volta i
Richmond Fontaine hanno preferito spegnere la luce e ascoltare l'inquietudine americana.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE