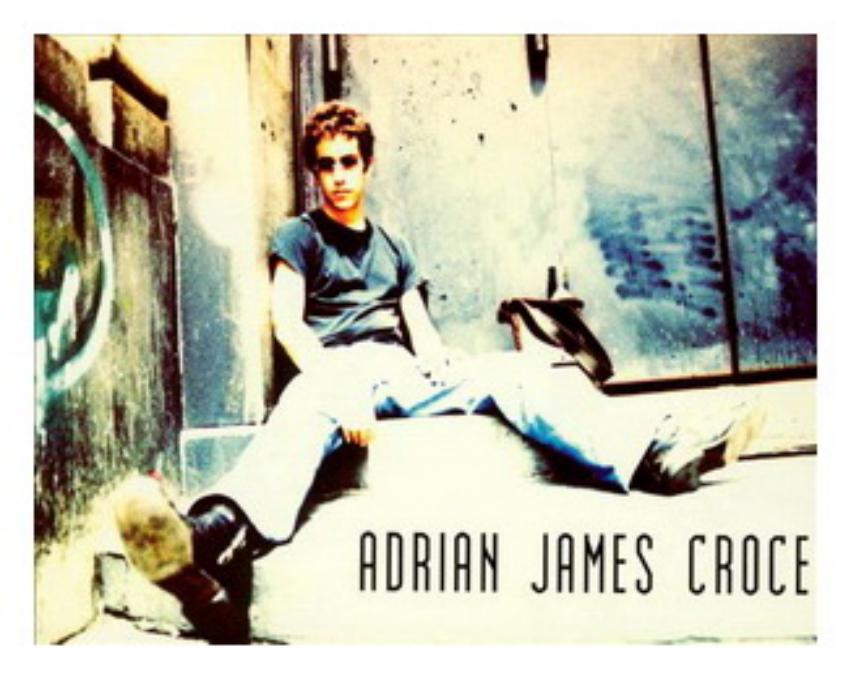
Tra tutti i figli d'arte (e di papa) saliti alla ribalta,
A.J. Croce è sempre stato il più simpatico. Un po' perché alle sfortune della vita (oltre a perdere il padre, Jim, in un incidente aereo, è parzialmente cieco dall'età di quattro anni) ha risposto con un'energia e uno spirito non indifferenti; e un po' perché ha scelto un profilo discreto, molto meno tormentato e complesso di parecchi suoi coetanei (da
Jakob Dylan a
Jeff Buckley, la cui strumentalizzazione, come a suo tempo la celebrazione, ha ormai raggiunto livelli indecorosi).
Un motivo aggiuntivo, ma non meno importante l'hanno avuto i suoi dischi e in particolare
That's Me In The Bar, Fit To Serve e lo splendido
Transit dove si mostrava un pianista capace di coinvolgere ed eccitare spaziando da Randy Newman ai Little Feat, dal Big Easy sound al Tom Waits più romantico e generoso. Nonostante ciò nella sua carriera discografica qualche problema deve pur esserci se ad ogni disco deve cambiare etichetta e se qui si è imbarcato in un disco che vorrebbe essere un nuovo esordio (e infatti ha lo stesso titolo del debutto,
A.J. Croce, prodotto da T-Bone Burnett) e forse aggiungere qualcosa in più alle caratteristiche.
Un tentativo, nemmeno troppo nascosto, di trovare la melodia giusta, la canzone che funziona anche alla radio, il ritornello da mandare a memoria, l'arrangiamento elegante e piacevole. Dato che il talento non gli manca (anzi), figurarsi se AJ. Croce non riesce a mettere insieme un disco di pop songs e infatti si comincia subito in quella direzione:
Don't Let Me Down sembra costruita seguendo alla lettera il manuale delle istruzioni del mainstream.
Inizio ad effetto, ritmo schematico in quattro quarti, una strofa ed esattamente dopo trenta secondi (come richiesto dagli standard) ecco il ritornello. Tutto molto lineare, compresi l'inciso, l'assolo di chitarra finale (bello) e le background vocals, ma un po' troppo schematica e risaputa per come conoscevamo A.J. Croce. Provarci, dopo quattro album bellissimi e più o meno sconosciuti, è un diritto, ma insistere per tutto un disco, lascia un po' perplessi.
Il ritmo, il calore, le sfumature vanno persi a favore di un repertorio dichiaratamente Beatles o giù di lì (
Baby Tonight, Lying On The Ground, Too Soon, Hung Up), sempre in cerca della melodia perfetta e un po' ruffiana. Niente di grave, per carità: i musicisti che l'accompagnano suonano egregiamente (
Davey Faragher al basso è passato per i Cracker, John Hiatt ed è attualmente negli Imposters di Elvis Costello;
Brian McLeod ha cominciato nei misconosciuti Wire Train ed è oggi uno dei maggiori batteristi americani;
Greg Leisz è un polistrumentista che ha suonato con tutti, a partire da Dave Alvin) e AJ.
Croce il suo talento non l'ha buttato alle ortiche, però affiora anche qualche momento di stanchezza (
Alone And Together, What You Want) e una canzone,
Cold, che sembra ricostruita pari pari attorno a
Time di Tom Waits. Molto meglio i profumi West Coast di
Call Me Dear, quella gran ballata che è
Almost Angeline e il crescendo finale di
How Long dove ritroviamo il pianista irruente e caloroso che conoscevamo.
Troppo poco, però, per garantire il nuovo corso di A.J. Croce.
 Vita, parole e geografia umorale del PELLE
Vita, parole e geografia umorale del PELLE